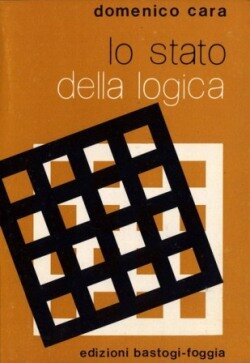È scritto all’anagrafe e in ogni documento che mi appartiene: Maria, il nome che ho cancellato da questa Franca che rimane. Scomparso dalla mia firma. Un solo nome: due sillabe che mi pronunciano, che mi sottraggono al silenzio. Sono già molte per esistere. E anche la voce degli altri mi ha riconosciuto, mi ha chiamata Franca, semplicemente: si è fermata, come non ci fosse bisogno di dire ancora.
È scritto all’anagrafe e in ogni documento che mi appartiene: Maria, il nome che ho cancellato da questa Franca che rimane. Scomparso dalla mia firma. Un solo nome: due sillabe che mi pronunciano, che mi sottraggono al silenzio. Sono già molte per esistere. E anche la voce degli altri mi ha riconosciuto, mi ha chiamata Franca, semplicemente: si è fermata, come non ci fosse bisogno di dire ancora.
Maria è il nome della madre di mia madre. Mi piace sentire l’eco di questa parola, la profondità che apre indietro, nelle generazioni, come un filo che ci si passa nel buio. In questa ripetizione mi sembra di riportarla in vita, di donarle ciò che le appartiene, che le è dovuto; ha a che fare con qualcosa che non ha fine, che sprofonda alle mie spalle, fino a ciò che non mi è visibile né conosciuto. Da me, oltre me, non so come e se continuerà.
Lei è la madre di mia madre, di mia madre, di mia madre. Come scorrendo i grani di un rosario potrei ripeterlo ancora fino a renderla un’espressione muta, un’onda sonora che viene e ritorna nel silenzio. Maria è il nome che ogni donna porta. E davvero nelle nostre campagne marchigiane non c’era madre che non desse a sua figlia questo nome, come invocazione, come ringraziamento. Se non era il primo nome era il secondo, per custodirla.
Ma chiamerò Maria, la madre di mia madre, anche nonna, con l’affetto intatto dell’infanzia, incorniciandola in quegli anni della sua vita in cui ci siamo conosciute. Mi addormentavo spesso accanto a lei, nella metà del letto che era del marito, andato quando avevo quattro anni. Prima di chiudere gli occhi, distese su spesse lenzuola di lino, le sue parole si disegnavano come cerchi nel silenzio; il suo petto era un libro di pagine non numerate che terminavano a un passo dal sonno. Riprendeva la mattina, quando la seguivo nei suoi lavori di casa, in cucina, in cantina, nel pollaio. Tra le sequenze di suoni che ripeteva a memoria c’erano le preghiere. Insieme a queste mi ha insegnato un gesto che assomigliava a quello di legarsi le scarpe: un incrocio che si formava, se eseguito esattamente. Con la punta delle dita si tocca il centro della fronte, il centro del petto, la spalla destra e poi la sinistra. Come un laccio che ti tiene unita, che ti riporta al centro del tuo cuore che è sempre il cuore di un altro. Ogni volta che inizia qualcosa, che ti metti in cammino, segni questa croce su di te come faresti se ti trovassi su una riva, sulla terra bagnata, di fronte a un vetro umido e a ogni altra cosa che può essere scritta. Dice: sono qui, in questo punto esatto. E anche: mi affido a questo tempo e a questo spazio, a questo momento e a questo luogo. Non farmi perdere, tienimi stretta nel tuo sguardo. Chi legga questo messaggio non so dirlo. So che è un segno che presto si cancella, che bisogna ripetere di nuovo. È un po’ come con le scarpe allacciate la mattina per andare. Se le trovi slacciate poi durante il giorno, non puoi andare avanti molto, ti fermi un istante e ricominci.
Gli ultimi anni della sua vita, prima di addormentarsi, mia nonna aveva l’abitudine di chiedere “la benedizione”: una piccola croce che un altro doveva segnarle sulla fronte. Una malattia molto dolorosa, alle ossa, la portava a chiamare a voce alta sua madre, ripetutamente. Accorrevamo a vedere che cosa volesse, di che cosa avesse bisogno; spesso chiedeva di spostare un po’ la tenda, di avvicinarle qualcosa, spesso era soltanto un pretesto per vederci accanto a lei. Da adolescente mi ero quasi abituata a quella litania, e quando mi sembrava solo un capriccio tornavo presto alle mie cose. Chiamava sua madre, noi eravamo soltanto figli, figli dei figli, non potevamo consolarla, sollevarla tra le braccia, stringerla al petto, lontano dal dolore. Una notte, accorsa di malumore al suo richiamo di bambina, con un’irritazione trattenuta che chiedeva che cosa c’è, mi sono sentita chiedere per la prima volta la benedizione. Non c’era nessun altro in casa. Mia madre era uscita dimenticandosene. Toccava a me. A me che già non credevo, che avevo perso quel gesto che mi aveva consegnato come una vecchia chiave di cui non si ricorda la porta. Potevo farlo io? Ne ero capace? Distesa a letto, non poteva abbandonarsi al sonno. Aspettava. Mi aspettava. Nel silenzio mi affidava un potere. Dal fondo della stanza mi sono avvicinata; con un dito le ho tracciato una piccola croce sulla fronte. Sembrava placata, rasserenata. Sono tornata in camera mia.
Ci sono due strade che da Lucrezia portano a Cartoceto. Si attraversa una zona di recenti case residenziali colorate a pastello e ci si ritrova a una biforcazione con due cartelli che indicano la stessa meta. Prendo sempre quella di sinistra, che sembra più breve. Prima di arrivare al paese si sale a Salomone, un nome che continua a ripetersi nella mente cercando qualcosa che richiami l’antico re della Bibbia fino a questa piccola frazione di case, mentre la strada svolta, inizia a costeggiare uliveti e un grande noceto. Si arriva presto a un incrocio a t: la strada da cui veniamo porta a Lucrezia, quella che prenderemo, sulla destra, a Cartoceto, quella a sinistra a Saltara e a Calcinelli. Qui è un monumento ai caduti della prima e seconda guerra: un tempietto chiaro con le pareti laterali interne piene di piccole foto ovali in bianco e nero e scritte che rinviano a una morte declinata in tre casi: per ferite, per malattia, in prigionia. Il luogo: dall’Albania all’Africa, dalla Russia a Creta. Nella parete centrale una lastra di pietra riproduce in rilievo l’immagine della Madonna delle Grazie. È per lei che oggi sono salita qui, a una quindicina di chilometri da Fano, seguendo in auto il cammino che mia nonna faceva a piedi fin da bambina. L’affresco miracoloso era proprio in questo incrocio, in un’edicola, prima di essere staccato e collocato nel Santuario accanto al paese. Riconosco le linee di quell’antico disegno, tante volte ritrovato a casa, sul comodino di mia nonna, dentro un libro, nella credenza. Un santino come un segnalibro, un fiore schiacciato tra le pagine: ricorda il punto fino a cui ti ha portato la vita, il punto da cui puoi continuare. I suoi colori di erba, di polvere e di terra li ritroverò presto nella piccola cappella costruita per lei, con le pareti adornate di cuori d’argento. Non resto a lungo. In questi monumenti ai caduti sento spesso qualcosa di estraneo: un fasto che a malapena riesce a coprire un inganno, un’impostura; i tratti mascherati, ufficiali, di una celebrazione che non riguarda davvero queste vite di uomini trascorse in un cerchio di case tra le colline prima di essere chiamati alle armi. Guardo gli occhi di tutti divenuti scuri nelle foto, seguo la data e il luogo di una stessa morte organizzata, diramata in divisioni e schiere. Qualcuno è stato disperso. Forse una forma di salvezza: non essere più trovati, riconosciuti accanto ai documenti. Finalmente liberi. Il tempo che passa, il vuoto che si apre e si disegna di innumerevoli strade che portano a casa o verso un’invisibile terra straniera, tra lingue sconosciute che arrivano all’orecchio, bisbigli che assomigliano a quelli dei morti. Ma sono tra i nomi dell’elenco. Non sono sfuggiti. Sono qui anche loro.
Faccio pochi passi fuori, verso l’incrocio; considero le tre direzioni possibili. Respiro per un attimo la vertigine di quel luogo che doveva essere sacro, difeso dai demoni che si nascondono nelle chiome degli alberi, nelle siepi ai margini delle strade, scuotendole come un vento; frantumano l’immagine che avevamo riconosciuto e custodito allo specchio, chiamandola con il nostro nome, trattenendola, difendendola dalle ombre che affiorano come da un velo d’acqua. Un soffio di voce all’orecchio ripete io, come la fiamma di una candela subito spenta dal vento. Bisogna proteggerla con il palmo di una mano e camminare fino all’immagine santa, alla madre dipinta.
Sono qui, al Santuario, nella cappella della Madonna delle Grazie. A quest’ora del pomeriggio in tutto il Santuario solo i miei passi e il silenzioso coro delle candele bianche. Le più grandi crepitano a tratti nel silenzio come franando, ricadendo su se stesse. Chi le ha piantate qui conosce la durata della loro vita. Può venire a guardarle come un orologio, un calendario. Quando la più vecchia viene schiacciata dal tempo, ridotta al suolo come una buccia, un tappo, subito la fiamma passa a un’altra. Sono tre infatti, ognuna in un periodo diverso della vita: la prima è quasi intatta, la seconda è a metà, la terza verso la fine. In una colonnina d’acciaio se lasci cadere una moneta ne ricavi un tintinnio metallico come di salvadanaio: puoi portare con te un santino o prendere una candela piccola da piantare nell’aiuola insieme alle altre. Accanto è una colonia di ceri rossi; cimiteriali, è vero, ma basta guardarli pochi secondi per scorgere la minuscola fiamma protetta, quasi una vita che si muove lentamente nel loro grembo.
Dici che si può pregare anche così, con una mano che segna il bianco del foglio. È lo stesso bianco che è apparso a un lembo della tua veste, che si è portato via la bocca di un angelo che ti vegliava; è il bianco da cui ti hanno ritagliata, che ti contorna ancora. Noi torneremo lì, in quel vuoto da cui sei apparsa, da cui appari con occhi grandi e labbra minute, in boccio. Hai un’aureola intagliata di motivi geometrici, un antico disco solare; un velo ti nasconde i capelli. Su un ginocchio è seduto un bambino già uomo, vestito di verde come gli angeli e i prati, ti guarda stringendo una croce. Anche noi a cercare i tuoi occhi, a leggere il silenzio sul tuo viso.
Tra i cuori alle pareti cerco per gioco le iniziali del mio nome. So che sono venuti qui anche per me. Si sono inginocchiati al banco di legno, hanno acceso una candela. Andavo verso la morte, con l’istinto di un animale che migra. Ma anche le piccole divinità del cielo e dell’acqua si ingannano: le ritrovi spiaggiate, prese nelle reti, confuse dalle ferite.
Tutto quanto accade, è dentro i tuoi occhi quieti. Mentre il nostro piccolo cuore implode e si frantuma, non pompa più amore alle estremità del corpo.
Nel silenzio soltanto il rumore di un aspira-fumo e quello delle auto di fuori che spostano l’aria, come raffiche di vento. Prima di andare torno per un’ultima volta a guardare la tua immagine di muschio, ocra e sabbia bagnata. È come se fossi venuta dalla terra, vincendo la terra, il suo sgretolarsi. Resteranno i tuoi occhi, un segno su un muro scrostato.
Franca Mancinelli, Dentro un orizzonte di colline e altre prose, in C. Babino (a cura di) Femminile plurale. Le donne scrivono le Marche, Vydia, Macerata 2014.